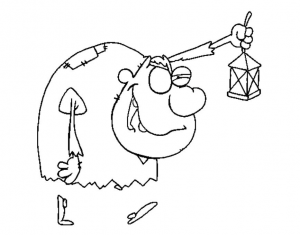Avevo preso a frequentare una bottega di libri rari dal giorno in cui avevo visto il nome e il cognome di Gesualdo Bufalino, scrittore di Comiso e mio professore d’Italiano all’Istituto Magistrale ” Giuseppe Mazzini” di Vittoria nella seconda metà del XX secolo, guardando per caso dei bigliettini da visita, sparsi dentro una scatola rettangolare di legno, in parte scheggiata da colpetti di unghie non sempre innocue, in parte cenericciata da migliaia d’impronte di polpastrelli dalla dubbia lindura e che, orgogliosa delle sue ferite e del suo grigiume, stava posta al centro di un vetusto scagno.
Così puntualmente il martedì e il giovedì, alle undici, dopo le prime due ore d’insegnamento a scuola, passavo dall’antiquario per scambiare quattro chiacchiere e avere suggerimenti da intenditore per l’acquisto di qualche testo che mi avrebbe potuto interessare, ma soprattutto per gettare uno sguardo all’ingresso della bottega –con quel misto di attrazione e di paura, che, in determinati momenti della vita, è il preludio di grandi sventure– su un segnalibro gigante di sapore kafkiano in cartone bianco, raffigurante un uomo che strozzava con le sue mani quello che a me parve sempre essere un nero avvoltoio, a cui seguiva, nello spazio sottostante, la scritta “Libreria antiquaria Giancarlo Gatto succ. Berruto”- 10123 Torino, via S. Francesco da Paola 10 Bis, tel. 011836636, e che si concludeva con l’invitante e ardimentosa frase “Si acquistano Libri e Intere Biblioteche”.
La mia visita al “Gatto succ. Berruto” era diventata tanto un’abitudine che, in quei due giorni della settimana, io non riuscivo ad andare alla Biblioteca Nazionale di Piazza Carlo Alberto, dirimpettaia del Sardo-Piemontese Palazzo Carignano, se prima non avessi fatto questa tappa di cultura antiquaria, immancabilmente salutato dal sempre più spaventevole e ripugnante segnalibro gigante con l’uomo che strangolava l’avvoltoio nero.
Di tanto in tanto acquistavo un libro, sia perché avevo un reale bisogno per il mio lavoro d’insegnante e di ricercatore, sia perché il suo formato e la sua copertina suscitavano il mio interesse, sia perché potevo continuare a sfogliare, senza stare sullo stomaco del libraio, vecchi volumi le cui pagine ingiallite e imperlate di verdastre chiazze di muffa portavano evidenti segni delle stagioni passate.
Io notai un giorno, all’interno della bottega, un anziano signore, il cui viso, somigliantissimo al mio, mi ricordò subito un uomo che io incontravo ogni mattina quando andavo a prendere il tram per recarmi a scuola o nel primo pomeriggio, ritornando a casa, e che io avevo preso a ritenere il mio Doppio.
La mia sede di lavoro era in provincia, a Carmagnola. Io facevo sempre la stessa strada, prendevo il medesimo tram, salivo persino sull’identico treno. Non ho mai chiesto il trasferimento a Torino, perché mi trovavo a mio agio con gli alunni e in esaltante contrapposizione ideologico-politica con i colleghi, vecchi tromboni del ’68, e perché il viaggio in treno mi permetteva di leggere di riflettere di scrivere. E, poi, in fondo, tornavo a ripetere le stesse cose, non disdegnando di considerarmi “un pigro freudiano”, avendo fatto mio uno dei principi fondamentali della psicoanalisi: “ricercare soltanto ciò che porta piacere ed eliminare ciò che comporta dolore”.
I titoli dei libri da scorrere con l’occhio negli scaffali mi distrassero dall’osservare l’uomo che mi assomigliava tantissimo e che io non vidi più nella libreria, dopo che mi rivolsi all’antiquario per pagare, secondo me a buon prezzo, un testo, che ritenevo ancora valido sulle “Epopee” degli antichi popoli europei, su cui da tempo avevo soffermato la mia attenzione.
Mi diressi, quindi, alla Biblioteca Nazionale, compilai la carta d’entrata 0949 e andai ad occupare uno dei tavoli della sala di lettura. Io cercavo di fare, senza peraltro riuscirci, qualche scarabocchio su dei fogli, dove brevi ma numerose linee d’appunti letterari contendevano un dito di spazio a veloci e scarni giudizi globali sui miei alunni, quando l’uomo, che credevo il mio Doppio e che avevo visto, non molto tempo prima, nella bottega del “Gatto antiquario”, venne a sedersi proprio di fronte a me. Tirò fuori dalla sua borsa dei libri che sistemò alla sua sinistra, poi dei quaderni certamente di non antica data, perché, se il loro bordo era di un rosso stantio, le loro copertine erano invece di un nero zigrinato ancora ardito. E cominciò a sfogliarli.
Chiunque avesse sbirciato da lontano quest’uomo, che aveva un’aria strana inconsueta, avrebbe pensato subito che fosse sprofondato nella lettura, ma io che sedevo proprio davanti a lui mi resi conto che girava stancamente le pagine dei suoi quaderni, dopo averle soltanto fissate distrattamente. Notavo nel suo volto malinconia delusione sconforto, come se le parole scritte su quei fogli, che non mostravano ancora i segni del tempo, fossero il risultato di un lavoro rivelatosi, alla fine, non solo inefficace, ma anche inutile.
Pure io avevo sfogliato le pagine dei miei quaderni a quel modo, chiedendomi spesso se mai avessero potuto diventare pagine di libri. La mia iniziale indifferenza nei confronti del mio Doppio diventò dapprima turbamento, poi commozione, ragion per cui decisi di rivolgergli la parola: “Sono seduto, forse, di fronte a uno scrittore?” Il mio Doppio sollevò lo sguardo, che teneva sopra i quaderni, e, come se rientrasse nella realtà quotidiana da un metafisico mondo iperuranio, mi diede una occhiata insocievole, che manifestava lo stupore e il fastidio di colui che aveva dovuto interrompere una fantastica navigazione ad occhi aperti.
“Ho chiesto se lei è uno scrittore”- ripetei con un filo di voce.
Ancora a disagio nel suo impacciato imbarazzo, il mio Doppio riuscì a dire soltanto: “Uno scrittore? No, sono semplicemente uno che scrive, uno che ha scritto tanto”.
Per cercare di farlo uscire definitivamente dal suo intorpidimento mentale, velato ora di amarezza, ora di abbattimento profondo, che lui non faceva niente per nascondere agli occhi di chi lo osservasse, continuai: “Non ha mai pensato di pubblicare le sue pagine?”.
Mi parve che il mio Doppio, in un primo momento, cercasse di prendere una posizione più comoda, nella sedia che occupava, in realtà si lasciava scivolare all’indietro lentamente e, nel suo volto, c’era dipinta una pensierosa espressione di reale mestizia.
Io dissi ancora: “Ho proferito qualche parola di troppo? L’ho forse turbata?”.
Lasciando gradualmente la coda di quello che era ormai soltanto un impacciato imbarazzo, il mio Doppio riprese: “Sono sulla soglia dei settant’anni. Credo di aver vissuto la mia vita in modo unico, irripetibile. Leggendo le pagine di centinaia di libri di giornali di riviste, osservando le azioni degli uomini e su di esse riflettendo, ho creato una prosa che ritengo originale, ma non interessante per il mercato editoriale: una prosa debole, in cui si muovono personaggi deboli, che affermano una filosofia debole della vita e del mondo. Ma non è detto che i miei concetti inediti esprimano contenuti meno validi di quegli degli autori di successo. E’ stata certamente la lettura poco meditata delle pagine da me scritte, da parte dei critici, a condannarmi all’anonimato. Ma io, che non ho avuto il privilegio della pubblicazione, io Ignazio Biscari, ultimo rampollo di un principesco casato siciliano che vive in dignitoso orgoglio la decadenza e l’attesa della fine, leggerò a lei, perché so che cerca di farsi strada nel campo della letteratura –senza scendere a compromessi con nessuno dei potenti di turno– le linee essenziali del mio pensiero”.
Allora aprì il primo dei suoi quaderni e cominciò a leggere brani di quanto aveva scritto. Io ascoltavo e catturavo come un magnete di rara potenza, incollandoli nella mia memoria, i contenuti culturali di quest’uomo, che aveva trascorso tutta la vita nella lettura e nella ricerca di una via personale alla letteratura.
E fu come se il tempo, per me, nella Biblioteca Nazionale di piazza Carlo Alberto, si fermasse; ed io mi facessi famelico e rapace avvoltoio di parecchi lacerti letterari scritti da Ignazio Biscari da rielaborare su nuove basi e da vivificare dandogli vitalità e vigore. Tanto che quando il mio Doppio si alzò e andò via, io continuai a fissare a lungo la sedia vuota che lui poco prima aveva occupato, nello stesso tempo avvertendo una interiore sensazione di pienezza tematica e concettuale mai avuta prima, che attendeva soltanto di imboccare la strada maestra di una scrittura che rappresentasse la realtà naturale e la condizione umana con uno stile di notevole forza espressiva.
Io non passo più dalla bottega dell’antiquario, non vado più alla Biblioteca Nazionale, non compro più libri recenti o rari. Leggo i testi che gli editori piccoli medi grandi mi fanno pervenire con preghiera di una recensione e quelli che, ogni anno, mi pubblicano. Non ho più rivisto quell’uomo di cultura con cui parlai un giorno in Biblioteca, quell’Ignazio Biscari che mi fece dono della lettura dei suoi originali concetti di “letteratura debole” diventati i fondamentali “contenuti forti ” delle mie opere.
Mi sono trasferito in provincia, dove la vita e la mentalità senza dubbio meno frenetiche e più flemmatiche, un po’ monotone e forse anche più sonnacchiose rispetto alla città, a me sortiscono l’effetto di far sembrare le giornate più lunghe. Ho lasciato l’insegnamento, vivendo con la pensione datami dallo Stato e i diritti d’autore dei miei libri e di quanto vengo scrivendo sui quotidiani sui settimanali sui mensili.
Un giorno trovandomi in città per parlare con il direttore di una rivista di cultura, che mi aveva proposto di stendere un lavoro sulla via della solitudine interiore dello scrittore guerriero, decisi di passare dalla bottega di quel “Gatto antiquario”, che avevo frequentato per così lungo tempo, quando ero ancora un inseguitore di sogni letterari, prima di raggiungere la notorietà. Ma nella libreria non entrai. Poggiata la mano sulla maniglia esterna della porta a vetri rividi, tra gli altri, che scorrevano i titoli dei vecchi libri collocati negli scaffali, proprio Ignazio Biscari, il mio Doppio misterioso con il quale ero venuto in culturale contatto nella Biblioteca Nazionale di piazza Carlo Alberto anni prima. Anzianissimo ormai, bianchi tutti i capelli, una sciarpa verderame con righe giallo zolfo al collo sopra un pesante cappotto nero, gli occhiali dagli spessi vetri rotondi, un berrettino simile a quello dei fuochisti francesi tra le due guerre mondiali, che lo accostavano tanto agli scrittori mancati della letteratura universale, con i quali la vita è stata sempre avara di riconoscimenti culturali.
Ignazio Biscari sfogliava le pagine di un antico e prezioso testo rilegato in tela di seta rossa con fregi blu cobalto.
Gli scaffali della bottega dell’antiquario segnati dai morsi delle tarme, la luce fioca che doveva favorire la consultazione e l’acquisto dei libri da parte degli amatori, l’età avanzata del ” Gatto antiquario” dei lettori e di quell’uomo, Ignazio Biscari, così assorti assorbiti quasi perduti tutti nella lontananza epocale di chissà quale prosa o verso d’autore, mi diedero l’impressione di trovarmi davanti alla muffa e alla polvere opprimente di una vecchia casa rugosa e fatiscente in abbandono.
Dopo il primo momento vissuto in preda a vivo stupore, anche se avevo aperto la porta, mi convinsi ancora di più a non entrare nella libreria.
“Certamente il mio Doppio avrà ripreso ad inseguire il miraggio di una pubblicazione!” – dissi ad alta voce, ridendo in modo sconsiderato.
Dall’interno della bottega tutti i presenti mi guardarono profondamente meravigliati schifati a causa di quelle parole di dileggioso sarcasmo pronunciate e della mia fragorosa sguaiata risata.
Ignazio Biscari sollevò gli occhi dal testo che teneva tra le mani e mi osservò con quella che, a me, parve l’umile e tremula espressione di amarezza e di dolore propria della persona nobile e colta, che ha commesso l’imperdonabile errore di leggere le linee essenziali del suo pensiero a un borghese istruito, figlio legittimo dell’ingratitudine.
Io rimasi fermo davanti alla porta a vetri in tutto simile a colui che avesse preso una terribile botta in testa, né mai più riuscii a dimenticare ciò che successe quel giorno.
Comprendendo in seguito, sempre più, che da quel momento qualcosa mi causava vuoto nella mente, facendo ineluttabilmente svanire quelle linee essenziali del pensiero che Ignazio Biscari mi aveva letto e di cui io mi ero fatto rapace avvoltoio in un lontano mezzogiorno di alcuni anni prima. Perché da quegli occhi, solo apparentemente inoffensivi del mio Doppio, emanava un così potente magnetismo che generava dentro di me la sconcertante impressione che Ignazio Biscari succhiasse dal mio cervello ogni contenuto creativo che mi aveva elargito e che successivamente mi mettesse al collo le sue scarne e ossute mani, strozzandomi come faceva l’uomo con l’avvoltoio di kafkiana memoria del segnalibro gigante che, senza patire i segni del tempo, stava ancora davanti alla libreria antiquaria del “Gatto succ. Berruto”.
Da allora la mia attività di scrittore si è interrotta, i rapporti con il mio editore si sono guastati. Ogni volta che mi sono seduto al tavolo del mio studio per cominciare un lavoro nuovo, io sono stato sopraffatto dalla fortissima sensazione che Ignazio Biscari fosse davvero l’uomo che si riprendeva, con i suoi occhi, i pensieri che io avrei voluto esprimere e che strangolava con le sue scarne e ossute mani l’avvoltoio predatore ingrato quale io mi ero dimostrato nei suoi confronti.
Così io sono caduto in una miseria spirituale e materiale profonda, oscillando il mio vivere quotidiano nella condizione umana ora del fannullone, ora del vagabondo, ora del clocard, e senza più anima mi trascino sotto i portici della Cittadella Universitaria o faccio avanti e indietro all’interno e all’esterno della stazione ferroviaria, i miei abiti e il mio corpo sempre più divenendo simili ad un ammasso di letame in cui trovano nutrimento e dimora stanziali colonie di insetti parassiti, che giorno dopo giorno mi vanno riducendo a quattr’ossa rinsecchite dentro una lamina di ruvida pelle, non lontano preludio d’immondo carcame e di protocollo del nulla.
Antonio Cammarana
 Ignazio aveva frequentato la sala da barba non per apprendere l’arte e metterla da parte, ma perché la madre intendeva sottrarlo alle insidie e ai pericoli della strada. Dentro la sala e nel tratto di strada di fronte, zio aveva la possibilità di tenere Ignazio sott’occhio, osservando i sui movimenti e vigilando su di lui continuamente. Ignazio aveva il compito di sciacquare il pennello con l’acqua corrente, dopo che al cliente era stata fatta la barba; di spazzolare le spalle allo stesso dopo il taglio dei capelli; di dare alcuni colpi di scopa sul pavimento per eliminare la peluria sparsavi; di ringraziare il cliente dopo il pagamento del servizio.
Ignazio aveva frequentato la sala da barba non per apprendere l’arte e metterla da parte, ma perché la madre intendeva sottrarlo alle insidie e ai pericoli della strada. Dentro la sala e nel tratto di strada di fronte, zio aveva la possibilità di tenere Ignazio sott’occhio, osservando i sui movimenti e vigilando su di lui continuamente. Ignazio aveva il compito di sciacquare il pennello con l’acqua corrente, dopo che al cliente era stata fatta la barba; di spazzolare le spalle allo stesso dopo il taglio dei capelli; di dare alcuni colpi di scopa sul pavimento per eliminare la peluria sparsavi; di ringraziare il cliente dopo il pagamento del servizio.