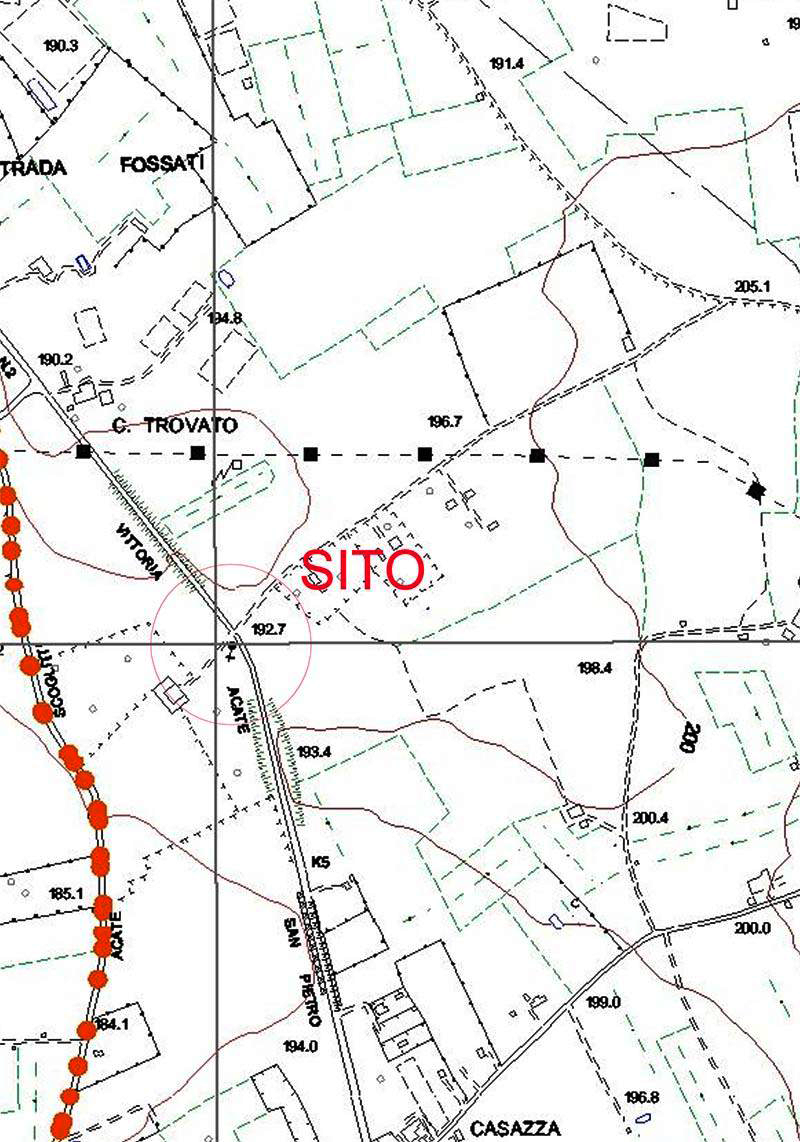Alla data del 25 dicembre 1914, dallo scoppio della Prima guerra mondiale erano trascorsi 151 giorni. Il conflitto, che tutti gli Stati europei belligeranti vevano creduto di potere condurre e risolvere in modo rapido e travolgente, si era trasformato da guerra di movimento in guerra di posizione e aveva già fatto milioni di morti di feriti e di mutilati.
Da una trincea all’altra si sperava nella fine della guerra o almeno in una tregua. E quando, sul fronte occidentale, ai soldati dell’Intesa (Gran Bretagna, Francia, Russia) e degli Imperi Centrali (Germania e Austria- Ungheria) fu chiaro che non ci sarebbero state nè l’una nè l’altra accadde quello che gli alti comandi delle due coalizioni in guerra mai avrebbero ritenuto possibile: spontaneamente soldati inglesi e tedeschi uscirono dalle trincee e cominciarono a camminare nella terra di nessuno, terra che odorava ancora di brandelli di carne umana in putrefazione e di polvere da sparo, ma nell’aria non si sentirono risuonare né colpi di fucile né raffiche di mitragliatrice.
Quelli che fino a un momento prima si consideravano nemici irriducibili da uccidere si trovarono faccia a faccia lungo i cinquanta cento duecento metri che separavano una trincea dall’altra. E un incontenibile desiderio di umana fratellanza universale spinse il soldato tedesco e il soldato inglese a stringersi la mano e a scambiarsi gli auguri di Buon Natale in un’atmosfera che niente pareva avere di reale e di concreto. Ma chi erano quegli uomini che da oltre cinque mesi sentivano quotidianamente il rombo del cannone, le raffiche delle mitragliatrici, il fischio delle pallottole di fucili, o vedevano i corpi dei compagni disintegrati dalle granate o trafitti dalle baionette, se non uomini comuni strappati al calore all’affetto e all’amore dei familiari e al lavoro quotidiano, uomini che facevano i contadini gli artigiani gli impiegati i professionisti e che erano stati scaraventati da un giorno all’altro nella fornace incandescente di una guerra che non avevano voluto, una guerra che oggi li faceva eroi, domani li faceva vigliacchi, oggi li alienava, domani li mutilava o li uccideva.
Mentre gli uomini di governo e degli alti comandi militari, che la guerra avevano voluto e scatenato e che li mandavano a morire per la conquista di poche decine di metri di terreno, che sarebbero state perdute alcune ore o alcuni giorni dopo, trascorrevano il tempo lontani dalle trincee e dai campi di battaglia tra discorsi oziosi e manovre politiche idiote o inconcludenti, pranzi, baciamano, musiche e balli con signore dell’aristocrazia o della ricca borghesia industriale bancaria e imprenditoriale, bicchieri di champagne e di cognac, salutati dall’immancabile “prosit” alla faccia dell’umile fante, che schiacciava pulci e pidocchi all’interno del pantano della trincea o cadeva colpito da un cecchino quando meno se lo aspettava o nel corso di un attacco o di un contrattacco.
Come scrive Martin Gilbert, uno dei più autorevoli storici della Prima e della Seconda guerra mondiale, tutto cominciò la sera della vigilia di Natale e proseguì nel corso della giornata del Santo Natale.
“Quel Natale, pressochè ovunque nella terra di nessuno, in prossimità delle linee inglesi e in alcuni settori delle linee francesci e belghe, i soldati fraternizzarono con i tedeschi. A dare il via erano sempre questi ultimi, o con un messaggio o con un canto. Nei pressi di Ploegsteert un ufficiale britannico, il capitano R.J. Armes, che parlava tedesco, dopo avere ascoltato con i suoi uomini un soldato nemico cantare una serenata, lo invitò a continuare e il tedesco intonò “I due granatieri di Schumann”.
Allora da entrambe le linee gli uomini uscirono dalle trincee e si incontrarono nella terra di nessuno”. Per tutta la giornata del 25 Dicembre 1914, in diversi punti del fronte, il nemico strinse la mano al nemico augurando Buon Natale, scambiando sigari e tavolette di cioccolato, stellette e distintivi, bottoni delle divise militari, bicchierini di whisky, facendo provviste di paglia e di legna da ardere, seppellendo i morti che si trovavano tra le opposte trincee, mentre ora cappellani inglesi ora cappellai tedeschi leggevano le preghiere e ci si irrigidiva sull’attenti quando i miseri resti dei corpi dei militari inglesi francesci belgi e tedeschi venivano calati all’interno delle fosse scavate in quel giorno santo.
Per un giorno, un solo giorno, per tutta la durata della Prima guerra mondiale, quella che cominciò ad essere la terra di nessuno fu la terra di tutti e il silenzio non fu il silenzio di piombo che precedeva un attacco o un contrattacco, ma il silenzio del giorno della nascita del Salvatore, rotto soltanto dalle voci ritornate amiche di uomini che da un giorno all’altro erano diventati nemici per volontà di sovrani ministri diplomatici e plenipotenziari.
Quando gli alti comandi dell’Intesa e degli Imperi Centrali furono informati che i soldati fraternizzavano diedero ordine agli ufficiali di fare rientrare, come pecore negli ovili, le truppe nelle rispettive trincee, convalidando la tesi che l’odio tra le genti d’Europa lo alimentavano coloro che la guerra non la facevano e se ne stavano lontani dal fronte, ormai diventato un immenso formicaio sia sotterraneo che alla luce del sole.
Già nella giornata di Santo Stefano, il 26 Dicembre 1914, i combattimenti riprendevano sotterrando, nella terra di nessuno, quello slancio spontaneo di fratellanza, che aveva visto il nemico stringere la mano al nemico, camminandogli accanto anche per pochi metri, respirare un’aria non infettata dalla polvere da sparo, dai gas e dall’odio che avrebbe portato lentamente alla rovina i popoli dell’Europa nel volgere dei successivi quattro anni di guerra.
Antonio Cammarana